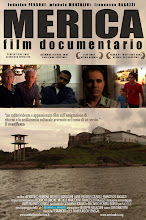Proiezione di Merica a MONTECATINI FILM VIDEO - Sezione: Quando il corto ha la memoria lunga - Ore 15.30
Screening of Merica at the Montecatini Film Video Festival - Category: Quando il corto ha la memoria lunga - 15.30



I suoi lavori sono visibili su www.giusepperagazzini.com
http://www.youtube.com/user/giusepperagazzini
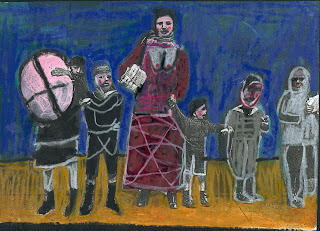
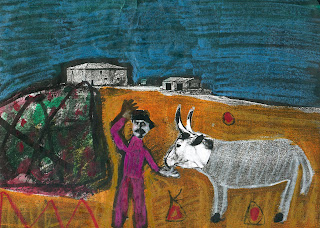


 Nell'ultimo numero di FilmDoc (nov-dic 2008), la rivista dell'AGIS Liguria, Alessandro Tinterri dedica ampio spazio a Merica nel suo articolo "Cinema documentario e storie di emigranti".
Nell'ultimo numero di FilmDoc (nov-dic 2008), la rivista dell'AGIS Liguria, Alessandro Tinterri dedica ampio spazio a Merica nel suo articolo "Cinema documentario e storie di emigranti".La storia che mi appresto a riportare è un racconto vero, vissuto dallo zio di mia nonna Miranda, Francesco, che agli inizi del Novecento emigra negli Stati Uniti. I sentimenti e le emozioni di questa storia mi hanno sempre accompagnato fin dalla mia infanzia perché l’ho sempre sentita raccontare e per me piccolo bambino lo zio d’ America era diventato un mito. Approfondendo poi gli studi sull’argomento ho capito le tante difficoltà che questa persona ha dovuto affrontare e risolvere da sola.
Sono quasi quattro milioni gli italiani che tra il 1880 e il 1930 approdano negli Stati Uniti su un totale di emigrati italiani che scelsero mete transoceaniche di 9 milioni circa. Occorre precisare che queste cifre non tengono conto dei rientri che rappresentarono un fenomeno massiccio:circa la metà degli emigrati rimpatriò. Inizialmente gli immigrati provenivano dalle regioni del nord in seguito da quelle del sud e per tutti l’ impatto con il nuovo mondo si rivelava difficile fin dai primi istanti: ammassati negli edifici di Ellis Island, o di qualche altro porto come Boston, Baltimora,o New Orleans gli immigrati,dopo settimane di viaggio, affrontavano l’esame a carattere medico e amministrativo,dal cui esito dipendeva la possibilità di mettere piede sul suolo americano. La severità dei controlli fece ribattezzare l’ isola della baia di New York come “l’Isola delle lacrime”.
Dopo l’ unificazione dello Stato italiano, la pressione demografica, la difficile situazione economica soprattutto nelle campagne avevano creato disoccupazione e miseria, a cui si cercava di sfuggire con l’ emigrazione. Solo alla fine degli anni ’80 l’Italia, da paese d’ emigrazione, è divenuto paese d’ immigrazione:albanesi, rumeni, tunisini, marocchini, filippini, cinesi,ecc. si sono stabiliti da noi temporaneamente o in maniera definitiva. Anche loro hanno dovuto affrontare un viaggio spesso pieno di rischi e in condizioni disumane, talvolta analoghe a quelle in cui si trovarono molti anni fa gli immigrati italiani.
Per molti decenni gli emigrati viaggiarono verso l’ America a bordo di piroscafi o bastimenti in condizioni igienico - sanitarie disastrose. L’affollamento, la pessima qualità del cibo, la sistemazione senza precauzioni igieniche in cuccette o sul ponte favorivano l’ insorgere di malattie, creavano comunque situazioni di gravissimo disagio. L’ attraversata spesso duravo 30 giorni con il rischio di naufragi e incidenti.
Per ricostruire la storia dell’ immigrazione e le storie degli emigrati servono moltissimi documenti, perchè si tratta di un fenomeno complesso e molto vasto.
Gli storici devono infatti indagare la situazione economica, sociale e culturale del paese di origine nell’ arco temporale preso in esame, devono conoscere l’entità numerica degli spostamenti, le modalità del viaggio, le mete di destinazione, i modi di interazione con la nuova realtà, ma anche le aspettative, le condizioni di vita degli emigranti. I documenti che lo storico utilizza si trovano negli archivi pubblici (giornali, leggi e ordinanze, regolamenti, ecc.), negli archivi privati (lettere, diari, memorie autobiografiche, fotografie, ecc.), in testi pubblicati (romanzi, poesie, canzoni, ecc.), oppure devono essere costruiti intervistando coloro che hanno vissuto l’ esperienza dell’ emigrazione. Il viaggio dello zio Francesco è un percorso lungo che ho sintetizzato trascrivendo fatti e avvenimenti che a me sembrano significativi, raccogliendo informazioni da diari, lettere e racconti orali di mia nonna.
L’uomo, da sempre è alla ricerca della serenità, di una vita costruttiva, ricca di alternative ma soprattutto di libertà, di pensiero e di azione che gli permetta di realizzarsi come persona.Il viaggio dello zio Francesco, se così si può definire è un viaggio costretto verso una realtà a lui sconosciuta e piena di imprevisti, ma con una speranza certa, trovare la libertà che gli permetta di esprimersi come essere umano, come artista per sé stesso e per gli altri.
Nasce a S. Ambrogio nel 1894 e inizia il suo lavoro come scalpellino molto giovane, professione che svolgerà anche suo fratello Mario(mio bisnonno), e che lo porterà a diventare maestro d’ arte della scuola Paolo Brenzoni. Il viaggio dello zio inizia in Francia nel porto di Hyères.
Novembre 1914
Dopo lunghi giorni trascorsi su mezzi di fortuna siamo arrivati al porto francese di Hyères assieme a Zampieri, Semprebon e Zorzi mi imbarco sul bastimento e mi appresto a questa nuova vita. Lascio la mia casa, la mia terra, i miei affetti, la mia amata Ancilla e parto per piantare in quel luogo sconosciuto questo mio sentimento di libertà. Non so cosa e chi troverò, non so se ci arriverò, ma il senso di esistere mi impone e mi spinge a farlo. Sarò come un animale in preda al suo istinto primitivo:la sopravvivenza.
Destinazione Brooklin dove zio Noè mi aspetta. Chissà se quando arriverò ci sarà ancora. Quanti dubbi, quante paure, quante incertezze. Parto, parto per tutti, anche per quelli che non sono potuti partire, per i soldati che si apprestano ad una guerra senza senso, per le madri, le mogli, per i lavoratori sfruttati, per le idee che ti portano a stare male, ad essere in crisi con te stesso, ma non puoi soffocare o far finta che non ci siano.
Parto da disertore della Patria, la mia Patria, parto, perché rimanere equivale a morire; forse morirò in ogni caso e piango, piango di paura.
Così lo zio Francesco inizia il suo lungo viaggio, che terminerà dopo più di 30 giorni al porto di Ellis Island dove rimarrà altri 40 giorni. Il viaggio in bastimento è stato un viaggio tormentato, difficile, sconosciuto il mare, alle volte buono, alle volte cattivo.
6 Dicembre 1914
Cara Ancilla,
è già 10 giorni che siamo in viaggio, tu non potresti mai credere. Dormiamo, mangiamo sempre nello stesso posto, non abbiamo spazio per muoverci. Mi manca molto il mio paese, la famiglia, gli amici, alle volte vorrei tornare indietro, ma ci facciamo coraggio a vicenda con la speranza di arrivare presto. Ho conosciuto un prete, che verrà a Brooklin con noi e ci tiene compagnia nelle lunghe sere, quando, cullati dal mare, calmo e pacifico ci lasciamo andare nell’ ascolto dei passi dell’ Esodo della Bibbia. Sarà lui a sposarci quando mi avrai raggiunto, spero presto.
Un abbraccio forte.
Arrivato a New York abiterà assieme ai suoi amici e allo zio Noè in un piccolo appartamento a Brooklin.
La migrazione a catena portò alla costituzione delle “little italies” nelle principali città statunitensi, interi quartieri abitati da italiani nelle cui strade la lingua ufficiale erano i vari dialetti dei paesi di provenienza, con negozi in cui si vendevano prodotti di importazione italiani. Spesso quartieri una volta residenziali si svuotarono per lasciare il posto ai ‘tenements’, definiti come, secondo la descrizione della Immigrant Commission nel 1900: edifici di cinque o sei piani, a volte sette, lunghi poco più di sette metri e larghi trenta con uno spazio libero di tre metri sul retro, per dare luce e arie alle stanze su quel lato. Ogni piano è generalmente diviso in quattro appartamenti, essendoci sette stanze su ogni lato dell’ ingresso, che si estendono sulla strada verso il retro. Delle 14 stanze su ogni piano solo quattro ricevono luce ed aria diretta dalla strada o dal piccolo cortile sul retro “generalmente lungo le pareti laterali dell’ edificio vi è quello che viene chiamato ‘ condotto dell’ aria ’ cioè un incavatura della parete profonda 70 cm e lunga da 15 a 18 m e alta quanto l’ edificio. Questi condotti funzionano come trasmettitori di rumori, odori e malattie e quando scoppia un incendio diventano una cappa infiammabile rendendo spesso difficile salvare l’ edificio dalla distruzione”. New York era la città con più tenements degli Stati Uniti: nel 1909, secondo i dati della stessa commissione c’erano 102.897 tenements houses con una popolazione di 3.775.343 abitanti. Oltre il 79% della popolazione di new York abitava in tenements.
Il 1 febbraio del 1915 lo zio si sposa a Brooklyn con la zia Ancilla che nel frattempo lo aveva raggiunto. La sera stessa si mettono in viaggio per li Vermont dove nella cittadina di Barre gli amici li stanno aspettando. Qui lo zio aveva trovato lavoro assieme agli altri emigrati. In questa zona degli Stati Uniti ci sono tuttora molte cave di marmo che gli permettevano di lavorare portando a termine i lavori commissionati e permettendo alla piccola famigliola di andare avanti. Nel 1916- 1917 nascono le sue due figlie ,Elina e Leia. Terminata la Prima guerra mondiale lo zio con tutta la famiglia torna in Italia. Abiterà a S. Giorgio e continuerà a lavorare come scalpellino.Quando il fascismo va al potere lo zio si sente nuovamente l’uomo in gabbia di un tempo, l’uomo privato della libertà, l’artista che non può manifestare la propria idea.
Allora non resta che ripercorrere i passi di un tempo e con tutta la famiglia riparte. I quattro membri, due bimbe piccole, la moglie e lo zio si imbarcano nel porto di Genova e ripartono verso l’ ignoto. Anche questa volta il viaggio sarà lungo e pesante, quando arriveranno al porto New York per un periodo abbastanza lungo non troveranno una dimora fissa,la casa non è un qualcosa di fisico ma diventa un rifugio. Questo peregrinare non è molto lontano dai fatti di cronaca che si sentono o si leggono sui giornali dei nostri giorni. Sono gli stessi uomini,le stesse donne, che per gli stessi motivi partono per luoghi a loro sconosciuti e che quando dopo giorni o mesi di peripezie arrivano si sentono umiliati aggrediti e giudicati. Forse il viaggio di questo zio non è servito a niente? Quanti zio Francesco si vedono oggi nelle nostre città sulle nostre strade o bussano alle nostre porte. Solo nel 1927 lo zio riesce a stabilirsi definitivamente nel Passaic città nello stato del New Jersey dove diventerà un artista famoso e richiesto in tutto l’est degli Stati Uniti.
Negli anni seguenti proseguirà gli studi nel settore del marmo facendo corsi di disegno, scultura, diventando maestro scultore e nelle più importanti città americane. I suoi lavori più importanti sono presso il National Archives e Supreme Court Building in Washington D.C. e la Cattedrale di St. John the Divine, Riverside Cathedral e il Four Freedoms Memorial Building, di New York City; ma la sua opera più importante ed impegnativa è stata per la Cathedral of Mary Queen in Baltimore. Lo zio Francesco non tornerà più in Italia, se non per visitare i parenti, ma la nostalgia per il suo paese natale lo accompagnerà per tutta la sua vita.
“L’idea di questo documentario è nata dalla volontà di un’analisi seria sull’immigrazione in Italia, qualcosa che andasse al di là degli slogan allarmistici e dei tanti luoghi comuni sugli immigrati. L’Italia è uno dei pochi paesi al mondo che ha conosciuto un’emigrazione di massa e che dopo meno di un secolo si è trovata a dover accogliere grandi flussi di immigrati alla ricerca di migliori condizioni di vita.
Un’analisi dell’immigrazione poteva partire proprio da un parallelo con quel gigantesco fenomeno che è stata l’emigrazione italiana, in particolare quella verso l’America iniziata a fine ‘800. Abbiamo pensato che il Veneto fosse la massima rappresentazione di questa “inversione migratoria”: prima terra povera, adesso porto d’arrivo di migliaia di migranti. Il Brasile era il suo contraltare ideale: considerato il paese del futuro cento anni fa, fu la terra d’approdo di moltissimi italiani. Oggi, invece, molti brasiliani cercano di trasferirsi in Italia e in Veneto in particolare.
Oltre che un’analisi dell’immigrazione in Italia, il documentario è anche un viaggio tra gli italiani all’estero, una comunità di cui si è cominciato a parlare davvero solo da pochi anni e che conta decine di milioni di persone. Dopo le elezioni politiche del 2006, decise anche dal loro voto, all’improvviso l’Italia sembra aver scoperto la loro esistenza ma il quadro che se ne dà e spesso approssimativo se non addirittura inventato. Non abbiamo preteso di comprendere tutti i sentimenti degli italiani all’estero, ma abbiamo cercato di mostrare molti brasiliani di origine italiana che guardano alla terra dei loro nonni con grande rispetto, addirittura devozione e speranza. Per questo hanno forse un’immagine un po’ distorta dell’Italia, che però alimenta il loro attaccamento e la loro speranza di un ricongiungimento.
In un secolo gli italiani sono passati da una povertà assoluta, che li spingeva all’ emigrazione, all’ essere oggi intolleranti verso chi bussa alle loro porte per gli stessi motivi. Ivi compreso gli stessi discendenti dei loro concittadini partiti all’estero per sfuggire alla miseria. In questo paradosso crediamo risieda il principale motivo di riflessione del film. Perché è assurdo che un popolo che ha tanto sofferto mentre emigrava in tutto il mondo abbia così tanta difficoltà ad accettare chi viene da fuori. Ed è ancora più paradossale che si tenda a discriminare molti immigrati sulla base della nazionalità quando poi, come mostriamo nel film, se qualcuno si presenta col passaporto italiano e con sangue italiano nelle vene, viene rifiutato lo stesso, perché è cresciuto in un altro continente.
Oltre che un’analisi del fenomeno migratorio in Italia e una panoramica sulle comunità italiane d’oltreoceano, il film vuole quindi essere prima di tutto una riflessione sulle condizioni contemporanee dell'appartenenza, dell'accettazione e del bisogno di riconoscimento sociale che si concentrano nell’esperienza migratoria. Noi speriamo che “Merica” possa, nel suo piccolo, mostrare tutto quell’ insieme di speranze, fatiche, incomprensioni e delusioni che sono al centro di tutte le esperienze migratorie del mondo, non solo quella italiana.”
Federico Ferrone, Michele Manzolini, Francesco Ragazzi
 PROIEZIONI / COMING UP
PROIEZIONI / COMING UP